Il fumo avvolgeva ogni cosa come ovatta e conferiva agli oggetti e alle persone un’aria di effimera magia. I bicchieri vuoti sul bancone di mogano formavano una fila disordinata, unica traccia delle parole confuse che si erano materializzate poco prima. Dall’altra parte del bancone, un uomo corpulento, calvo, molto sudato, asciugava, senza molta voglia, i bicchieri appena estratti dalla lavastoviglie. Su una delle pareti accanto al bancone, in una cornice economica, l’immagine di una bambina dai lineamenti delicati. Di fronte al barista un uomo, unico avventore a quell’ora così tarda, era magro e piuttosto pallido, indossava vestiti scuri di taglio sartoriale anche se piuttosto logori, dal suo labbro pendeva una sigaretta perennemente accesa. “Fammene ancora uno.” Disse il cliente tenendo lo sguardo basso sul bancone al quale era stancamente appoggiato. “Agli ordini! Purché sia l’ultimo e tu te ne vada presto, non ho voglia di stare qui con te tutta la notte!” Rispose il barista riempiendo il bicchiere che aveva in mano. Nel locale si diffondeva una musica, un blues lento che nessuno ascoltava ma che faceva compagnia ai due uomini, come il fuoco di un caminetto acceso ignorato da tutti ma che scalda l’ambiente. L’avventore bevve un sorso dal bicchiere, non era più molto sobrio. “Sai… barista… come ti chiami barista?” Bofonchiò dopo aver appoggiato il bicchiere. “Ben.” Rispose il barista con tono distratto continuando ad asciugare bicchieri. “Ben, un nome da bonaccione… Io sono William. Ben, un nome da grassone…” Continuò il cliente con la voce alterata da almeno due whiskey di troppo, Ben gli rivolse un’occhiataccia senza rispondergli. “Beh Ben, lascia che ti racconti cosa mi è successo, poi pago e me ne vado, facilmente non ci vedremo più.” “Basta che sia breve, tempo dieci minuti, chiudo e vado a casa, aggiungici il fatto che a me della tua storia non interessa un fico secco.” Disse Ben passando un panno piuttosto consunto sul bancone cercando di evitare William che vi appoggiato. “Come vuoi Ben ma fatto sta che un po’ di tempo fa, un tizio, uno che ho incontrato in un bar che assomigliava a questo, gira gente strana nei bar, non trovi?” Ben fece un gesto eloquente con la mano e continuò ad occuparsi delle sue faccende senza nemmeno voltarsi. “Insomma ero nuovo in quella dannata città ed avevo bisogno di pubblicità per la mia attività… Ho un’azienda di onoranze funebri…” Proseguì William che stava riacquistando un’improvvisa sobrietà nonostante i numerosi whisky che aveva bevuto. Ben alle parole “onoranze funebri” si fermò, prese una delle sedie che aveva già rovesciato su uno dei tavoli e vi ci sedette. William si voltò, il fumo della sigaretta del becchino continuava ad aleggiare nel locale assieme al blues. L’uomo vestito di scuro si appoggi voltato di spalle al bancone e continuò il suo racconto. “Ero nuovo in città e volevo farmi pubblicità, così decisi di frequentare il bar che si trova nella piazza principale di questa città, un locale pieno di fumo e di whisky dove girava gente di tutti i tipi. Una sera entrai in quel locale e notai appoggiato al bancone uno strano tipo, doveva essere uno straniero anche lui perchè i suoi abiti erano decisamente troppo eleganti per un postaccio del genere, di certo non mi facevo troppe domande, per me era sufficiente lasciare qualche biglietto da visita ed aspettare che qualcuno si decidesse a farsi… vivo, in Mason Lane, dove avevo preso in affitto una specie di ufficio. All’improvviso una voce risuonò alle mie spalle: “Sei un becchino vero?!” Il tono era piuttosto minaccioso, la voce era distorta come quella di chi ha nelle vene più alcool che sangue, mi voltai, era l’uomo che avevo notato poco prima, annuii. “Sì, mi occupo di onoranze funebri, le posso essere d’aiuto in qualche modo?” Continuai cercando di mantenere il mio conseuto distacco. Il tizio si appoggio malamente al bancone e mi disse: “Vuoi sentirla una storia davvero brutta? Poi ti dirò cosa mi serve”. “Certamente signore, se la posso aiutare, volentieri” Risposi io gentilemente. “Bene becchino! Prenditi uno sgabello, un doppio Jack e ascolta bene!”. L’uomo dagli abiti eleganti inizio a parlare: “ A Baton Rouge c’è un piccolo cippo a ridosso di quel maledetto muro di Trenton Street, una piccola targa d’ottone oramai ossidata dalla pioggia e dal vento, su quella targa una scritta: “Agnese 1925 – 1926 B.M.”. I passanti camminano e non ci fanno più caso eppure fino a pochi anni prima al posto di quel cippo c’era una bambina dagli occhi neri vestita di stracci che suonava una gusla, suonava melodie tristi ma dolcissime come doveva essere stata la sua anima. Quasi tutti i giorni passava di lì un uomo dagli abiti piuttosto eleganti con una valigetta dalla forma sinuosa e dal cappello con una piuma svolazzante, ogni volta si soffermava alcuni istanti ad ascoltare le note suonate dalla bambina dagli occhi neri e sorrideva, anche la bambina sorrideva, poi l’uomo lasciava cadere un quartino nella ciotola di latta tutta ammaccata che si trovava di fronte alla bambina e se ne andava. Un giorno quell’uomo notò accanto alla bambina una bambola di pezza fatta a mano e in modo anche piuttosto grossolano ed incuriosito chiese alla bambina chi fosse quella bambolina. La bambina con la voce squillante dei suoi undici anni rispose che era Agnese e che gliela aveva lasciata un passante il giorno prima, poi continuò dicendo che quella era la sua amica del cuore. L’uomo dalla valigia sinuosa sorrise e dopo aver lasciato il solito quartino nella ciotola proseguì lungo la via accompagnato dal sottofondo malinconico della gusla della bambina. Il natale si avvicinava e tutti erano impegnati con gli acquisti e passavano davanti alla bambina che visibilmente infreddolita continuava a suonare quello strano violino, i suoi occhi scuri sembravano quasi addormentati per il freddo e per la fame. Le carrozze passavano veloci sollevando spruzzi d’acqua e neve. Una di quelle maledette carrozze ad un certo punto sembrò essere impazzita, sbandò prima da una parte e poi dall’altra, il conducente urlava a tutti di farsi da parte finchè non si udì un rumore sordo di legno spezzato, una melodia interrotta da un’improvvisa stonatura, un urlo acuto soffocato, vociare di gente. Dalla carrozza scese quell’uomo elegante con il cappello dalla piuma svolazzante, era sconvolto e si precipitò verso il punto dell’impatto dove trovò una bambina a terra con un rivolo di sangue che le scendeva tra i capelli corvini, i suoi occhi neri come la notte avevano assunto il colore opaco della nebbia. La tenne tra le sue braccia per alcuni istanti, la pioggia scendeva e la gente attonita guardava la scena senza muovere un dito. Nel frattempo qualcuno aveva chiamato i Gendarmi ed un’ambulanza, ma era tutto inutile, quando arrivarono non fecero altro che portare via quel corpicino senza vita e fare alcune domande al conducente della carrozza. L’uomo dal cappello elegante raccolse la gusla, che a parte la corda spezzata era ancora in buone condizioni, e la bambolina, poi se ne andò in silenzio. Nei giorni seguenti fece prepare da un artigiano quel cippo che ancora si può vedere a Trenton Street anche se ora nessuno ci fa più tanto caso. La gusla invece la tiene con se, ha imparato a suonarla, non è tanto dissimile dal suo violino, la tiene stretta a se e la suona quando vuole ritrovare qualche istante si serenità, quando vuole rivedere quegli occhietti neri come la notte… “E’ Agnese è la mia migliore amica”. Alla fine del racconto rimasi piuttosto allibito, evidentemente l’uomo di cui stava parlando era lui stesso, ma cosa mi avrebbe chiesto? Lo guardai fisso negli occhi, aveva smesso di parlare, c’era solo il fumo attorno a noi, tutto il resto sembrava quasi non esistere, poi come un tuono: “Becchino! Giudicami! Tu che vedi la morte ogni giorno, per te la morte è un lavoro, la morte non ti scalfisce, solo tu puoi giudicarmi!” Non sapevo come rispondere alle sue parole, era evidentemente ubriaco eppure doveva avere un grosso peso a causa di quella faccenda. “Senta signore, io non posso giudicare nessuno, io mi occupo di chi è già stato giudicato, mi dispiace” Dissi con voce gentile ma sicura. Lui mi guardò con odio e poi si accasciò sul bancone, io decisi che era il caso di lasciare quel luogo, tuttavia decisi che non appena ne avessi avuta la possibilità sarei andato a Baton Rouge.” Così si concluse il racconto di William. Ben era rimasto ad ascoltarlo silenzioso per tutto il tempo. Il becchino si voltò verso di lui e notò che aveva gli occhi gonfi di lacrime. William si avvicinò al barista e gli appoggiò una mano sulla spalla. “È tutto finito Ben, so tutto, Agnese era tua figlia, lo so, l’avevo saputo fin dall’istante in cui ho messo piede qui, ma ora non piangere più.” Ben sollevò la testa e guardò lo strano avventore, il suo viso appariva disteso e disse: “È ora?” “Sì Ben è ora, seguimi, Agnese ci attende qui fuori.” Il barista si alzò in piedi e seguì William verso la porta del locale, i due uomini uscirono dal bar, fuori ad attenderli c’era una bambina dagli occhi neri vestita di stracci che suonava una gusla, suonava melodie tristi ma dolcissime come doveva essere stata la sua anima , il fumo che si trovava all’interno seguì i due uomini all’esterno del locale e li avvolse assieme alla bambina. Tutti e tre scomparvero in una folata di vento.





 Quello stupido uccello di legno era uscito gi
Quello stupido uccello di legno era uscito gi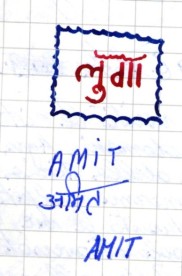 Jaipur, 28 Settembre 2006.
Jaipur, 28 Settembre 2006. – Quanto fa freddo nell’oceano?
– Quanto fa freddo nell’oceano? Recentente sono stati descretati alcuni documenti del KGB risalenti alla fine degli anni ’50 del secolo scorso secondo i quali non fu Jurij Gagarin il primo uomo a volare nello spazio nel 1961. Nei documenti descretati risulterebbe la missione di un altro cosmonauta mandato in orbita qualche mese prima di quella del militare di Klusino. Tuttavia, la sorte dell’uomo è avvolta nel mistero, o quasi. Il nome della capsula spaziale “fantasma” era Vostok 0 ed il suo pilota era il capitano collaudatore dell’aeronautica sovietica Igor Sokov. Il lancio del razzo vettore Semyorka dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan avvenne senza alcun problema così come la messa in orbita del Vostok. Le comunicazioni con Sokov erano buone, considerate le tecnologie dell’epoca, tutto stava procedendo alla perfezione. Secondo il programma della missione il capitano Sokov avrebbe dovuto iniziare le manovre di rientro dopo la prima ora di volo ma qualcosa non andò per il verso giusto. Le comunicazioni con la capsula si interruppero proprio nell’istante successivo in cui il cosmonauta aveva comunicato al centro di controllo l’inizio delle manovre di rientro. Alla base di Baikonur i tecnici erano scioccati e stavano facendo tutto il possibile per ristabilire un contatto con la capsula ma nulla. Non è ben chiaro che cosa fecero i tecnici a terra, non è chiaro quando decisero che era troppo tardi per salvare Sokov, non si sa nemmeno chi si prese la responsabilità di quella decisione. Ancor meno chiara è la causa di quel disastro. L’unica cosa sicura era che quel fatto sarebbe dovuto rimanere segreto per sempre. Accadde però un evento inaspettato. I tecnici della base di Baikonur non erano gli unici ascoltatori delle comunicazioni di Sokov. Due fratelli Italiani, radioamatori, erano riusciti ad intercettare le conversazioni tra il centro di controllo a terra ed il cosmonauta. I due radioamatori erano riusciti però anche dove i tecnici russi avevano fallito e quello che avevano captato era terribile.
Recentente sono stati descretati alcuni documenti del KGB risalenti alla fine degli anni ’50 del secolo scorso secondo i quali non fu Jurij Gagarin il primo uomo a volare nello spazio nel 1961. Nei documenti descretati risulterebbe la missione di un altro cosmonauta mandato in orbita qualche mese prima di quella del militare di Klusino. Tuttavia, la sorte dell’uomo è avvolta nel mistero, o quasi. Il nome della capsula spaziale “fantasma” era Vostok 0 ed il suo pilota era il capitano collaudatore dell’aeronautica sovietica Igor Sokov. Il lancio del razzo vettore Semyorka dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan avvenne senza alcun problema così come la messa in orbita del Vostok. Le comunicazioni con Sokov erano buone, considerate le tecnologie dell’epoca, tutto stava procedendo alla perfezione. Secondo il programma della missione il capitano Sokov avrebbe dovuto iniziare le manovre di rientro dopo la prima ora di volo ma qualcosa non andò per il verso giusto. Le comunicazioni con la capsula si interruppero proprio nell’istante successivo in cui il cosmonauta aveva comunicato al centro di controllo l’inizio delle manovre di rientro. Alla base di Baikonur i tecnici erano scioccati e stavano facendo tutto il possibile per ristabilire un contatto con la capsula ma nulla. Non è ben chiaro che cosa fecero i tecnici a terra, non è chiaro quando decisero che era troppo tardi per salvare Sokov, non si sa nemmeno chi si prese la responsabilità di quella decisione. Ancor meno chiara è la causa di quel disastro. L’unica cosa sicura era che quel fatto sarebbe dovuto rimanere segreto per sempre. Accadde però un evento inaspettato. I tecnici della base di Baikonur non erano gli unici ascoltatori delle comunicazioni di Sokov. Due fratelli Italiani, radioamatori, erano riusciti ad intercettare le conversazioni tra il centro di controllo a terra ed il cosmonauta. I due radioamatori erano riusciti però anche dove i tecnici russi avevano fallito e quello che avevano captato era terribile. Il nonno di Marco si chiamava Giovanni, classe 1925, emigrato in Argentina poco prima della fine della Guerra. Quaranta anni di lavoro in una carpenteria metallica, era diventato bravo ed il suo capo lo aveva sempre trattato bene, poi in pensione con una bella sommetta. Nel corso degli anni si era sempre tenuto in contatto con i suoi famigliari tramite una fitta corrispondenza, di carta, quella che profuma vecchio. Poi le lettere erano diventate un modo di comunicare antiquato ma Giovanni aveva continuato, non si era mai arreso alle tecnologie moderne, tuttavia le risposte dei parenti rimasti in Italia si diradavano con il passaggio a miglior vita dei suoi cari. La vita “italiana” di Giovanni era cambiata nel corso degli anni: nipoti nuovi, sorelle che non ci sono più, tutto attraverso lettere e fotografie che lui custodiva gelosamente. Un giorno di ottobre Giovanni decise di fare una passeggiata, quattro passi in riva al mare, viveva a poca distanza dal vecchio porto. Quella mattina una strana malinconia si era impadronita di lui e così si ritrovò, senza quasi rendersene conto, ad osservare l’oceano. L’acqua del mare gli bagnava i piedi e quelle piccole onde che arrivavano al bagnasciuga sembravano invitarlo a procedere oltre, ad inoltrarsi in quell’immensa distesa d’acqua verde e azzurra. Gli occhi del vecchio osservavano l’orizzonte, oltre quella sottile linea bianca c’era la sua casa, quella vera, sembrava così vicina, gli bastava arrivare a quella linea ed era di nuovo a casa sua. Anche se erano passati tanti anni e ormai Giovanni si era perfettamente integrato nel tessuto sociale del Paese che lo aveva accolto, si era sposato ma non aveva avuto figli, si era fatto molti amici, il denaro non era più un problema, insomma aveva fatto fortuna. Nonostante tutto questo non aveva mai considerato quel Paese come casa sua. L’Argentina gli aveva dato un lavoro e lui lo aveva sempre svolto con impegno, non si era mai messo nei guai: lui aveva dato tanto all’Argentina e tanto aveva ricevuto, erano pari. Mentre l’oceano si rifletteva nei suoi occhi chiari una lacrima scese sulla sua guancia e nella sua mente si fece largo una decisione, una vera e propria idea. Giovanni non avrebbe finto i suoi giorni all’estero da emigrante. Voleva ritornare a casa sua a Cividale, voleva ritrovare i suoi luoghi, rivederli prima che fosse troppo tardi. Di tutti i parenti con cui aveva corrisposto nel corso degli anni, l’unico che gli era rimasto era suo nipote Marco, il figlio di sua sorella minore. A dire la verità Giovanni e Marco, si erano scritti poco nel corso degli anni, in pratica solo per gli auguri di Natale e Pasqua. Marco era un affermato architetto, aveva cinquant’anni, una moglie e due figli grandi che ormai avevano ognuno una famiglia propria. Un giorno Giovanni decise di scrivere a Marco, l’unico legame che gli era rimasto con la sua terra. La sicurezza che si era manifestata quando era in riva all’oceano si stava scontrando con la realtà l’anziano emigrante non nutriva molta speranza in una risposta positiva da parte del nipote. Dopo circa tre settimane Giovanni ricevette la risposta del nipote e ne fu contentissimo, era al settimo cielo. Nella lettera Giovanni manifestò al nipote il suo desiderio di ritornare in Friuli per rivedere per un’ultima volta i luoghi della sua infanzia, non sarebbe stato di peso per Marco e la sua famiglia, avrebbe pagato tutto lui. Marco accettò volentieri la proposta dello zio e così iniziò tra loro una fitta corrispondenza cartacea e telefonica. Zio e nipote si misero d’accordo per tutti i preparativi: i documenti, l’alloggio, il programma della visita, etc. Per mezzo delle lettere organizzarono tutto nei minimi dettagli. Infine arrivò la sera prima della partenza e gli occhi azzurri di Giovanni osservavano l’orizzonte, una linea sottile sopra l’oceano, lo stesso mare dal quale era arrivato molti anni prima. Il vecchio pianse in silenzio preparò subito i bagagli e partì alla volta dell’Italia, del suo Friuli.
Il nonno di Marco si chiamava Giovanni, classe 1925, emigrato in Argentina poco prima della fine della Guerra. Quaranta anni di lavoro in una carpenteria metallica, era diventato bravo ed il suo capo lo aveva sempre trattato bene, poi in pensione con una bella sommetta. Nel corso degli anni si era sempre tenuto in contatto con i suoi famigliari tramite una fitta corrispondenza, di carta, quella che profuma vecchio. Poi le lettere erano diventate un modo di comunicare antiquato ma Giovanni aveva continuato, non si era mai arreso alle tecnologie moderne, tuttavia le risposte dei parenti rimasti in Italia si diradavano con il passaggio a miglior vita dei suoi cari. La vita “italiana” di Giovanni era cambiata nel corso degli anni: nipoti nuovi, sorelle che non ci sono più, tutto attraverso lettere e fotografie che lui custodiva gelosamente. Un giorno di ottobre Giovanni decise di fare una passeggiata, quattro passi in riva al mare, viveva a poca distanza dal vecchio porto. Quella mattina una strana malinconia si era impadronita di lui e così si ritrovò, senza quasi rendersene conto, ad osservare l’oceano. L’acqua del mare gli bagnava i piedi e quelle piccole onde che arrivavano al bagnasciuga sembravano invitarlo a procedere oltre, ad inoltrarsi in quell’immensa distesa d’acqua verde e azzurra. Gli occhi del vecchio osservavano l’orizzonte, oltre quella sottile linea bianca c’era la sua casa, quella vera, sembrava così vicina, gli bastava arrivare a quella linea ed era di nuovo a casa sua. Anche se erano passati tanti anni e ormai Giovanni si era perfettamente integrato nel tessuto sociale del Paese che lo aveva accolto, si era sposato ma non aveva avuto figli, si era fatto molti amici, il denaro non era più un problema, insomma aveva fatto fortuna. Nonostante tutto questo non aveva mai considerato quel Paese come casa sua. L’Argentina gli aveva dato un lavoro e lui lo aveva sempre svolto con impegno, non si era mai messo nei guai: lui aveva dato tanto all’Argentina e tanto aveva ricevuto, erano pari. Mentre l’oceano si rifletteva nei suoi occhi chiari una lacrima scese sulla sua guancia e nella sua mente si fece largo una decisione, una vera e propria idea. Giovanni non avrebbe finto i suoi giorni all’estero da emigrante. Voleva ritornare a casa sua a Cividale, voleva ritrovare i suoi luoghi, rivederli prima che fosse troppo tardi. Di tutti i parenti con cui aveva corrisposto nel corso degli anni, l’unico che gli era rimasto era suo nipote Marco, il figlio di sua sorella minore. A dire la verità Giovanni e Marco, si erano scritti poco nel corso degli anni, in pratica solo per gli auguri di Natale e Pasqua. Marco era un affermato architetto, aveva cinquant’anni, una moglie e due figli grandi che ormai avevano ognuno una famiglia propria. Un giorno Giovanni decise di scrivere a Marco, l’unico legame che gli era rimasto con la sua terra. La sicurezza che si era manifestata quando era in riva all’oceano si stava scontrando con la realtà l’anziano emigrante non nutriva molta speranza in una risposta positiva da parte del nipote. Dopo circa tre settimane Giovanni ricevette la risposta del nipote e ne fu contentissimo, era al settimo cielo. Nella lettera Giovanni manifestò al nipote il suo desiderio di ritornare in Friuli per rivedere per un’ultima volta i luoghi della sua infanzia, non sarebbe stato di peso per Marco e la sua famiglia, avrebbe pagato tutto lui. Marco accettò volentieri la proposta dello zio e così iniziò tra loro una fitta corrispondenza cartacea e telefonica. Zio e nipote si misero d’accordo per tutti i preparativi: i documenti, l’alloggio, il programma della visita, etc. Per mezzo delle lettere organizzarono tutto nei minimi dettagli. Infine arrivò la sera prima della partenza e gli occhi azzurri di Giovanni osservavano l’orizzonte, una linea sottile sopra l’oceano, lo stesso mare dal quale era arrivato molti anni prima. Il vecchio pianse in silenzio preparò subito i bagagli e partì alla volta dell’Italia, del suo Friuli. I primi tepori primaverili permettevano a tutti di tenere la finestre aperte anche fino alla sera e io stavo leggendo alcune lettere che mi erano giunte al mattino da parte di Mr Andrew a proposito di quella benedetta cripta che si trova sotto alla Cattedrale di Washington. In strada la tromba di Sonny faceva da sottofondo alla mia lettura e le note di “The Mooche” di Duke Ellington si profondevano lungo tutta la via. All’improvviso un boato, il rumore sordo di un’esplosione mi fece sobbalzare e subito dopo le grida della gente che era uscita in strada a vedere cosa fosse accaduto, mi affacciai alla finestra per vedere cosa fosse accaduto, lo feci per istinto senza pensarci, sotto c’era Sonny che appena mi vide gridò: “A Gallows Route! E’ successo qualcosa a Gallows Route!” Poi fuggi di corsa verso il quartiere malfamato. Scesi anche io di corsa e mi precipitai seguendo la folla verso Gallows Route. Una volta giunto sul posto lo spettacolo non era davvero dei migliori, un’intera palazzina era stata come sventrata e quelle prospicienti avevano i vetri totalmente disintegrati. Nell’aria si sentiva un acre odore di alcool misto a quello di legno bruciato. La gente intorno a me appariva scioccata, un po’ lo ero anche io, dannazione c’era qualcosa in quel quartiere che non andava eppure mai avrei pensato che sarebbe successo una cosa del genere, dannazione ho fallito, dannazione non c’è niente di peggio di una predizione che si avvera solo a metà. Battei un pugno sul muro per la rabbia, mi feci male, del sangue sgorgava dalla mia mano ma non me ne curai di fronte a quello spettacolo di distruzione. Dovevo recuperare la mia lucidità, raccogliere le idee o almeno i cocci di quelle che una volta erano delle idee. Quel dannato becchino intanto si dava un bel da fare, c’erano state delle vittime eppure lui sembrava serio quasi dispiaciuto, che bravo simulatore! Con tutta la grana che ti ha portato questo botto! Non dovresti essere così triste, razza di sotterra morti! I pensieri si affollavano mentre seguivo distrattamente i movimenti del becchino che gironzolava freneticamente sul luogo del disastro. Eppure qualcosa non mi convinceva, che si trattasse di un’episodio doloso era lampante ma diamine perchè proprio lì? Di chi era l’edificio che è esploso che cosa si faceva all’interno? L’odore di alcool non era solo un caso… Patson! Dannazione! Quel Reverendo ha le mani dappertutto!! Ma stavolta ha fatto il botto!! A quel punto notai che quel nero figuro del becchino si era fermato in un angolo vicino ad alcune macerie e stava come rovistando tra di esse, decisi di andare a vedere che cosa stesse facendo. Notai delle macchie di sangue sparse tutte attorno a quel punto e per terra un cadavere, o meglio, quello che ne rimaneva, infatti gli arti mancavano, c’era solo il busto e la testa era mancante della parte sinistra. Mr Blake con grande professionalità cercava di adagiare alla meno peggio quei resti mortali in una bara di legno chiaro e piuttosto nodoso. Non dissi nulla e mi allontanai al più presto prima di dare di stomaco. Lo sguardo di quell’uomo però mi rimase impresso: era freddo, distaccato, nelle sue pupille si potevano quasi vedere le monete scorrere e brillare. Ad un certo punto venni come svegliato da un rumore: “Mark, qui è tutto a posto, puoi caricare la cassa sul carro, fatti aiutare da Hermann”. Era la voce di Mr Blake, il suo lavoro era svolto per ora, professionale come sempre. Poi due ragazzotti robusti vestiti di nero raccolsero la cassa e la caricarono su un carro nero piuttosto malandato trainato da un cavallo nero che a giudicare dall’aspetto sembrava piuttosto avanti con gli anni. “Mr Blake noi andiamo, viene con noi?”. Sentii queste parole e poi la risposta di Blake :” No ragazzi andate pure, tornerò a piedi”. Il carro cigolante si allontanò e Blake rimase ad osservare la zona in cui poco prima vi erano i resti di quell’uomo. Il torpore in cui ero caduto poco prima per la vista di quei resti era svanito così decisi di farmi forza e di chiedere a Mr Blake qualche informazione, mi avvicinai a lui e gli chiesi: “Avete visto che disastro? Ho visto che avete raccolto i resti di una persona, avete idea di chi fosse?” Mr Blake fece un cenno negativo con il capo, il suo volto sembrava come sconvolto eppure non era la prima volta che vedeva un corpo ridotto in quelle condizioni. Ma soprattutto che ci faceva lì con una cassa già bella e pronta? Come faceva a sapere che gli sarebbe servita? No, no, quì non c’è nulla di chiaro. Diamine! Non è così che doveva andare, non si doveva giungere a questo punto! Chinai la testa e tenetti tra le mani, dovevo essere rimasto a lungo in quella posizione perchè non mi accorsi che sul luogo del disastro vi era anche una donna di mia conoscenza. Sollevai il capo e notai Miss Brooksfield a pochi passi da me, prima non l’avevo vista ma doveva esserci stata anche lei, anche lei doveva essere arrivata poco dopo l’esplosione. Incrociai il suo sguardo e lei per tutta risposta mi diede un ceffone dicendo con una voce rotta dal pianto: “Tu lo sapevi vero?!” Il gesto della giornalista mi aveva colto alla sprovvista ma riuscii comunque a mantenere il mio autocontrollo e risposi con voce calma e sicura: “Miss Brooksfield, io so sempre tutto, è il mio lavoro, non lo dimentichi.” Miss Brooksfield sembrava come impietrita, il suo volto era pallido come un lenzuolo i suoi occhi socchiusi, il suo incedere incerto, doveva essere stato un duro colpo per lei quello, perse i sensi un attimo e io la sorressi con le mie braccia. “Miss Brooksfield! Si riprenda! Forza! Reagisca!” Le gridavo mentre la scuotevo per farla rinvenire. Non appena si riebbe Miss Brooksfield mi guardò negli occhi per un’istante e poi fuggi.
I primi tepori primaverili permettevano a tutti di tenere la finestre aperte anche fino alla sera e io stavo leggendo alcune lettere che mi erano giunte al mattino da parte di Mr Andrew a proposito di quella benedetta cripta che si trova sotto alla Cattedrale di Washington. In strada la tromba di Sonny faceva da sottofondo alla mia lettura e le note di “The Mooche” di Duke Ellington si profondevano lungo tutta la via. All’improvviso un boato, il rumore sordo di un’esplosione mi fece sobbalzare e subito dopo le grida della gente che era uscita in strada a vedere cosa fosse accaduto, mi affacciai alla finestra per vedere cosa fosse accaduto, lo feci per istinto senza pensarci, sotto c’era Sonny che appena mi vide gridò: “A Gallows Route! E’ successo qualcosa a Gallows Route!” Poi fuggi di corsa verso il quartiere malfamato. Scesi anche io di corsa e mi precipitai seguendo la folla verso Gallows Route. Una volta giunto sul posto lo spettacolo non era davvero dei migliori, un’intera palazzina era stata come sventrata e quelle prospicienti avevano i vetri totalmente disintegrati. Nell’aria si sentiva un acre odore di alcool misto a quello di legno bruciato. La gente intorno a me appariva scioccata, un po’ lo ero anche io, dannazione c’era qualcosa in quel quartiere che non andava eppure mai avrei pensato che sarebbe successo una cosa del genere, dannazione ho fallito, dannazione non c’è niente di peggio di una predizione che si avvera solo a metà. Battei un pugno sul muro per la rabbia, mi feci male, del sangue sgorgava dalla mia mano ma non me ne curai di fronte a quello spettacolo di distruzione. Dovevo recuperare la mia lucidità, raccogliere le idee o almeno i cocci di quelle che una volta erano delle idee. Quel dannato becchino intanto si dava un bel da fare, c’erano state delle vittime eppure lui sembrava serio quasi dispiaciuto, che bravo simulatore! Con tutta la grana che ti ha portato questo botto! Non dovresti essere così triste, razza di sotterra morti! I pensieri si affollavano mentre seguivo distrattamente i movimenti del becchino che gironzolava freneticamente sul luogo del disastro. Eppure qualcosa non mi convinceva, che si trattasse di un’episodio doloso era lampante ma diamine perchè proprio lì? Di chi era l’edificio che è esploso che cosa si faceva all’interno? L’odore di alcool non era solo un caso… Patson! Dannazione! Quel Reverendo ha le mani dappertutto!! Ma stavolta ha fatto il botto!! A quel punto notai che quel nero figuro del becchino si era fermato in un angolo vicino ad alcune macerie e stava come rovistando tra di esse, decisi di andare a vedere che cosa stesse facendo. Notai delle macchie di sangue sparse tutte attorno a quel punto e per terra un cadavere, o meglio, quello che ne rimaneva, infatti gli arti mancavano, c’era solo il busto e la testa era mancante della parte sinistra. Mr Blake con grande professionalità cercava di adagiare alla meno peggio quei resti mortali in una bara di legno chiaro e piuttosto nodoso. Non dissi nulla e mi allontanai al più presto prima di dare di stomaco. Lo sguardo di quell’uomo però mi rimase impresso: era freddo, distaccato, nelle sue pupille si potevano quasi vedere le monete scorrere e brillare. Ad un certo punto venni come svegliato da un rumore: “Mark, qui è tutto a posto, puoi caricare la cassa sul carro, fatti aiutare da Hermann”. Era la voce di Mr Blake, il suo lavoro era svolto per ora, professionale come sempre. Poi due ragazzotti robusti vestiti di nero raccolsero la cassa e la caricarono su un carro nero piuttosto malandato trainato da un cavallo nero che a giudicare dall’aspetto sembrava piuttosto avanti con gli anni. “Mr Blake noi andiamo, viene con noi?”. Sentii queste parole e poi la risposta di Blake :” No ragazzi andate pure, tornerò a piedi”. Il carro cigolante si allontanò e Blake rimase ad osservare la zona in cui poco prima vi erano i resti di quell’uomo. Il torpore in cui ero caduto poco prima per la vista di quei resti era svanito così decisi di farmi forza e di chiedere a Mr Blake qualche informazione, mi avvicinai a lui e gli chiesi: “Avete visto che disastro? Ho visto che avete raccolto i resti di una persona, avete idea di chi fosse?” Mr Blake fece un cenno negativo con il capo, il suo volto sembrava come sconvolto eppure non era la prima volta che vedeva un corpo ridotto in quelle condizioni. Ma soprattutto che ci faceva lì con una cassa già bella e pronta? Come faceva a sapere che gli sarebbe servita? No, no, quì non c’è nulla di chiaro. Diamine! Non è così che doveva andare, non si doveva giungere a questo punto! Chinai la testa e tenetti tra le mani, dovevo essere rimasto a lungo in quella posizione perchè non mi accorsi che sul luogo del disastro vi era anche una donna di mia conoscenza. Sollevai il capo e notai Miss Brooksfield a pochi passi da me, prima non l’avevo vista ma doveva esserci stata anche lei, anche lei doveva essere arrivata poco dopo l’esplosione. Incrociai il suo sguardo e lei per tutta risposta mi diede un ceffone dicendo con una voce rotta dal pianto: “Tu lo sapevi vero?!” Il gesto della giornalista mi aveva colto alla sprovvista ma riuscii comunque a mantenere il mio autocontrollo e risposi con voce calma e sicura: “Miss Brooksfield, io so sempre tutto, è il mio lavoro, non lo dimentichi.” Miss Brooksfield sembrava come impietrita, il suo volto era pallido come un lenzuolo i suoi occhi socchiusi, il suo incedere incerto, doveva essere stato un duro colpo per lei quello, perse i sensi un attimo e io la sorressi con le mie braccia. “Miss Brooksfield! Si riprenda! Forza! Reagisca!” Le gridavo mentre la scuotevo per farla rinvenire. Non appena si riebbe Miss Brooksfield mi guardò negli occhi per un’istante e poi fuggi.